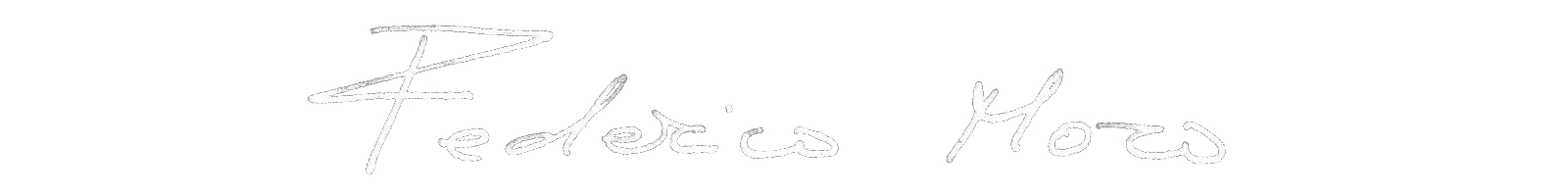Nel paese dei Guelfi e dei Ghibellini, dei Bianchi e dei Neri, in cui la norma è schierarsi senza sfumature o pro o contro, una disputa di lunga durata contrappone sostenitori e detrattori dell’impresa privata. La quale dai primi viene vista come motore di base dell’economia e, di conseguenza, quale unica creatrice e distributrice di ricchezza, fattore chiave di ogni progresso sociale. Secondo tale approccio, l’imprenditore è il vero protagonista delle trasformazioni e il politico deve limitarsi a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il dispiegarsi dell’energia produttiva. I celeberrimi «lacci&lacciuoli». Dall’altra parte, i detrattori ricordano che la generazione di ricchezza avviene inseguendo l’interesse privato dell’imprenditore, maggiore beneficiario della sua distribuzione, e passa allegramente sopra a qualunque considerazione di ordine sociale e ambientale. La «creazione», dunque, avverrebbe scaricandone i costi, specie quelli scaglionati nel tempo, sulle comunità, spesso più vittime che beneficiarie delle scorribande dell’imprenditore. Altro che potere equilibratore della «mano invisibile del mercato», diventa necessario l’intervento del politico per arginare i danni prodotti dall’eccesso di libertà d’impresa.
Noi italiani amiamo questo tipo di semplificazioni. Ci piace pensare all’imprenditore e al politico come a santi integerrimi oppure a criminali incalliti da contenere. Siamo certi sia una buona idea? Tanto per cominciare scomodiamo la Ragione. La quale si nutre di dubbi e ripercorre le curve della Storia perché sa che questa rappresenta il Racconto dell’Uomo, quindi delle sue migliori realizzazioni come delle peggiori nefandezze. L’Uomo non è né guelfo, né ghibellino, né bianco, né nero, ma una confusa marmellata di tutto un po’. Inteso sia come singolo che pensa, si emoziona, agisce, ma pure in quanto comunità. Lo sono anche l’imprenditore e il politico. Sul ruolo del primo aveva qualche dubbio persino il suo cantore agli albori della Rivoluzione Industriale, vale a dire Adam Smith che già nelle pagine del suo An Inquiry into the Nature and causes of the Wealth of Nations (1776) qualche domanda se l’era posta. Finì, infatti, per affidare in esclusiva allo Stato, pertanto al politico, difesa, giustizia e opere pubbliche: una bella interferenza sulla «mano invisibile del mercato», pure evocata dallo stesso autore, che regolerebbe automaticamente per il meglio la libertà d’azione dell’imprenditore.
L’identico problema venne poi affrontato da un altro protagonista del pensiero economico classico, John Stuart Mill, nei suoi Principles of Political Economy. Siamo nel 1848. Mill individua con precisione il dilemma: le forze naturali all’origine della produzione devono essere incanalate da un meccanismo che ne regoli l’esplosiva dinamica perché, mosse solo dalla ricerca del maggiore profitto possibile, sono indifferenti ai danni inflitti al territorio e alle macerie sociali lasciate dalla loro marcia. Stuart Mill prima di essere un pensatore acuto e brillante, fu un politico impegnato a fondo nella vita del proprio paese, la Gran Bretagna della Rivoluzione Industriale e dell’Impero. Oltretutto, conosceva quanto, a partire dalle sofferenze inflitte a milioni di esseri umani dal processo travolgente dell’industrializzazione, la riflessione socialista, declinata in forme libertarie e anarchiche oppure autoritarie e comuniste, aveva portato all’attenzione generale.
La lezione era semplice: l’Economia non poteva essere analizzata “in vitro”, come si trattasse di svelarne gli asettici meccanismi in vista del trionfo del più efficiente dal punto di vista della produzione e scambio delle merci. E basta. L’Economia, invece, era solo una delle possibili «manifestazioni dell’interscambio umano», tanto per citare chi sembrerebbe non centrare affatto in questo discorso e vale a dire un generale dedito alla riflessione strategica come Clausewitz. Il quale si riferiva alla Guerra, da cui la celebre definizione per cui questa non sarebbe altro che la «continuazione della politica con altri mezzi», pur non conoscendo Sun Tzu e probabilmente neppure troppo bene neppure Macchiavelli e Raimondo di Montecuccoli. Però era arrivato alla medesima conclusione: l’Uomo è animale teso all’autovalorizzazione, in ogni ambito, ed è pronto tanto da singolo che nelle collettività in cui si organizzi a percorrere qualunque via pur di raggiungere l’obiettivo. Non aveva per niente torto.
Da un lato, infatti, è vero che l’Uomo è dotato di spirito collaborativo teso a risolvere i problemi posti dall’esistenza attraverso il «Mutuo Appoggio» caro all’anarco-comunista libertario Petr Kropotkin, ma lo è altrettanto che in lui agisca un esasperato individualismo, incurante di tutto e di tutti, «l’Unico» di quel teorizzatore di frontiera che fu Max Stirner. Da qui la schizofrenia comportamentale del singolo e delle società per cui la stessa persona può essere buon padre di famiglia, studioso eccellente, allevatore di canarini e nazista spietato che apre con sovrana indifferenza le valvole del Zyklon B nelle camere a gas. Questa la realtà.
Vale anche per la questione che ci occupa in questo momento, la contrapposizione, apparente, tra imprenditore e politico. Come avevano perfettamente intuito Smith e Stuart Mill, resto quindi per semplicità nell’ambito del pensiero economico e liberale classico, bisogna stare attenti a mitizzare chiunque. Sostenere come accade di sentire oggi che l’imprenditore è il primo motore immobile di qualunque progresso sociale, e quindi non «deve dimostrare nulla» è per lo meno ingenuo. Esattamente come ritenere il politico l’affidabile guardiano del Bene Comune e di una legalità costruita sui veri bisogni di singoli e comunità. Perché entrambi, imprenditore e politico, interagiscono nel medesimo magma umano e devono, invece, di continuo dimostrare chi sono, cosa fanno e dove vogliono andare. Con la particolarità che, in un regime democratico, il politico si può anche sostituire, mentre all’imprenditore riesce di sfuggire alle proprie responsabilità se non viene intercettato dalla Giustizia. Sempre tenendo conto, poi, che i due mondi non sono affatto separati, ma rappresentano sempre e comunque semplici articolazioni del medesimo potere.
Conclusione. Questo non è un Mondo di puri, nemmeno uno dove ci sia qualcuno che possa arrogarsi il ruolo di giudice imparziale degli altri. Tutti hanno scheletri nell’armadio. Tutti mentono. Possiamo aspirare solo a migliorare lo stato delle cose, procedendo con molta fatica e spirito pragmatico. Nessuno ha la ricetta risolutiva in tasca. L’unica soluzione efficace finora individuata è il ricambio veloce di chi abbia responsabilità. Un “meccanismo” che non si adatta agli imprenditori, per i quali come detto non resta che affidarsi ai cani da guardia della giustizia, civile e penale, per frenarne il vizio di fondo: l’insaziabile e distruttiva sete di guadagno che li spinge ad aggirare ogni norma e qualunque limite. I «lacci&lacciuoli», spesso solo benemeriti divieti a tutela dei più deboli. L’hanno detto, tra gli altri, Adam Smith e John Stuart Mill con estrema chiarezza, cioè i Grandi Padri a cui tanti oggi dicono di ispirarsi e sarebbe intanto necessario conoscere meglio. Magari qualche volta anche provare ad applicare. Senza sconti, né scorciatoie.