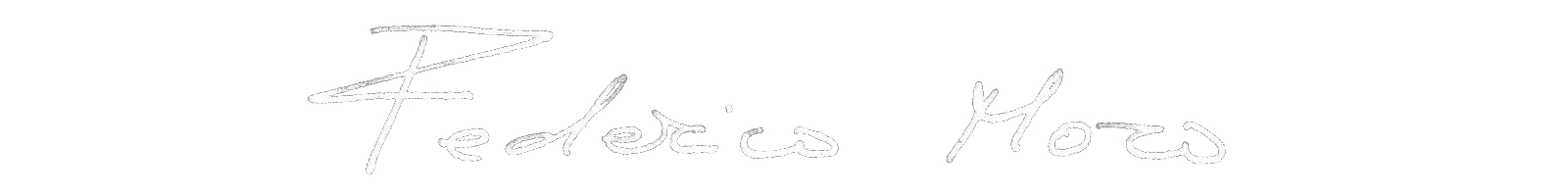Il nazionalismo è stato il demone del XIX e del XX secolo: ideologia potente, emersa dal corpo della Grande Rivoluzione di Francia e incrociatasi presto con il movimento culturale del Romanticismo, ha dimostrato stupefacente capacità di adattamento. Chiunque e ovunque può sentirsi e proclamarsi nazionalista. In particolare perché collegandosi all’idea di popolo ed essendo questa declinabile in infiniti sottoinsiemi ne ha assorbito la duttilità. Cosa sappiamo del nazionalismo?
Il primo punto da chiarire è il concetto di nazione. Esistono opinioni diverse in materia, ma quasi tutte concordano su alcuni punti di partenza. Nazione è una comunità che vive in un determinato luogo e condivide valori e cultura. Precisare quest’ultima, però, è già un bel problema. La definizione che trovo più interessante appartiene a un ebreo tedesco traferitosi negli Stati Uniti e che ha scritto in anglo-americano, George Mosse, il quale l’ha definita «mentalità suscettibile di diventare stile di vita»[1]. Un approccio molto convincente, perché ampio e flessibile. Collega la cultura agli esiti concreti con cui le comunità affrontano i loro problemi, la «civiltà», ma lascia aperta la via a sviluppi intellettuali e pratici. Vorrei che chi legge si soffermasse un momento sull’autore: ebreo, tedesco, pensa e scrive in anglo-americano essendo vissuto per lo più negli Stati Uniti. Di che nazionalità sarà?
La domanda non è affatto campata per aria, perché è quella fondamentale nella questione: si nasce o si diventa di una certa nazione? Se si nasce è chiaro che tra individuo e collettività s’instaura un legame immutabile. Nell’altro caso, la nazionalità diventa una possibilità in quanto appartiene al campo delle scelte. Il Romanticismo, al quale si deve l’aver rimodellato il concetto di nazione, non aveva dubbi e così ha innervato l’intero XIX e almeno metà del XX secolo del proprio punto di vista. A una nazione si appartiene in virtù della nascita, iure sanguinis. Le obiezioni, però, sono sorte rapidamente. Se così fosse, come inquadrare chi sia figlio di genitori appartenenti a nazionalità diverse? Un caso comune in particolare in quel primo esempio di globalizzazione chiamato colonialismo. Ovunque trapiantati, gli europei hanno cercato di conservare la propria identità peculiare. A prezzo di non pochi compromessi, però. Era abbastanza facile mantenersi distinti dalle popolazioni indigene, sempre dominate e spesso sterminate, molto più complicato evitare gli incroci tra i nuovi venuti. Se non altro vista l’esiguità dei numeri di partenza, che costringeva a far causa comune. Ciò non ha evitato i fenomeni di meticciato tra europei e indigeni, ma i primi hanno presto sorvolato del tutto sugli incroci tra quanti provenivano dalle varie parti del Vecchio Continente.
Casi evidenti si trovano ovunque nelle realtà emerse dalla dissoluzione degli imperi coloniali, con particolare evidenza però nelle Americhe. Preferisco, però, ricorrere a un esempio che trovo davvero singolare e che riguarda gli Afrikaners. Questi, infatti, di base sono calvinisti dell’Olanda meridionale, mescolatesi con un discreto numero di ugonotti, altri calvinisti ma francesi, e quindi con pochi tedeschi. In cerca di fortuna economica i primi in una colonia governata dall’allora Compagnia delle Indie Orientali olandese, in fuga dalle persecuzioni religiose in patria i secondi e i terzi. A cementarli, la comune fede nella lezione cristiana di Jean Cauvin, Calvino, il riformatore francese che trasformò la svizzera Ginevra nel suo personale esperimento sociale nel Cinquecento. Questi Afrikaners forgiano una lingua nuova. Di base è un dialetto olandese del sud, ma ha imprestiti dal francese, appunto, dal tedesco, dall’inglese, ma anche dalle lingue delle allora Indie Olandesi e da quelle malgasce, per via degli schiavi importati da tali aree. Si considerano una vera e propria nazione, “nazionalista” infatti si chiamava il loro principale partito, tant’è che nel 1925 abbandonano anche l’espressione “kaap nederlands” (olandese del Capo) a favore di afrikaans per indicare la lingua. Quindi, gli inventori dell’apartheid, regime di segregazione razziale della popolazione nera rispetto a quella bianca, chiamano loro stessi africani. Una tribù tra le tribù, verrebbe da dire, oppure una nazione tra nazioni di piccoli popoli[2].
Il caso è emblematico, ma ben altra portata hanno quelli americani. Da nord a sud. Cosa sono, infatti, Canadesi, Statunitensi, Messicani, Brasiliani, Argentini, tanto per rimanere tra i più numerosi? Parano lingue che di base sono europee, come l’afrikaans, ma che hanno subito radicali evoluzioni per l’innesto di vocaboli e costruzioni sintattico-grammaticali eterogenee quanto le pronunce. Esattamente come chi conosca l’olandese riconosce al primo colpo un akrikaner, così lo statunitense o il canadese vengono smascherati quando si esprimono nel loro inglese. E lo stesso vale per lo spagnolo del Messico o dell’Argentina e il portoghese dei Brasiliani. Questo perché l’incrocio di una cultura di governo con quelle dei tanti immigrati arrivati nel tempo ha prodotto una sintesi nuova. Lo stesso in altre parti del Pianeta.
Il processo di ibridazione è stato poi accelerato dalla globalizzazione, in particolare da quella delle informazioni, e dalla possibilità di circolazione istantanea assicurata dalla Rete. Oggi si è in grado di trovarsi in modalità virtuale ovunque e frequentare chiunque. Se ne sono accorti nelle cosiddette democrature o democrazie di comando. Bloccare l’accesso alla Rete, impedendo ai propri cittadini/sudditi di conoscere altri punti di vista è mossa inevitabile nel loro agire politico. Dalla Corea del Nord all’Iran, dalla Cina alla Russia è un coro unanime, mosso dallo stesso pretesto: salvare l’identità nazionale e i suoi valori fondativi. Ogni stato tende a identificarsi con una nazione e cioè con una comunità stanziata su un determinato territorio che condivide la medesima cultura. A partire dalla lingua. Perché questo sarebbe il lascito degli Antichi, l’imprinting genetico dei popoli, vale adire della realtà a cui gli stati sono chiamati a dare voce. Dicono i nazionalisti, a ogni latitudine. Dalla Catalogna alla Scozia, dall’Ucraina all’Indo-pacifico. Ne siamo sicuri?
La domanda è legittima perché la Storia ci racconta qualcosa di molto diverso. Se n’era già accorto in Austria un gruppo di studiosi poi chiamati Scuola di Vienna nell’immediato secondo dopoguerra. Cosa sostenevano? Riesaminando con occhio critico le vicende di vari popoli germanici, quelli le cui migrazioni hanno posto fine al Monto Antico e aperto la strada al Medio Evo, si erano resi conto che per ciascuno di essi esistevano dei vuoti plurisecolari nei rispettivi racconti. Il presente, già documentato con difficoltà, non si appoggiava su un passato verificato e controllabile bensì sul vuoto. Per colmarlo, ciascuno di essi aveva elaborato un proprio Mito delle origini, capace di dare continuità temporale alla storia collettiva e peso di antichità ai valori di base. Questi ultimi erano anche prodotto dei luoghi di origine, ma sopravvivevano altrove grazie alla loro conservazione e trasmissione da parte dell’etnos: perché patrimonio genetico del sangue.
Gli austeri professori della Scuola di Vienna, vaccinati tramite il nazismo dai residui neo-romantici capaci di veicolare le teorie razziste, si erano resi conto di avere davanti una mera costruzione teorica, elaborata, per così dire, a tavolino. Goti, Vandali, Longobardi, Franchi solo per citare qualcuno, presentano le medesime caratteristiche: a un certo punto un gruppo egemone, di solito guerriero, fonda il proprio potere su un racconto delle origini, un Mito, che collega gli appartenenti alla stessa realtà socio-politica tra loro e con un passato ancestrale condiviso. Tale gruppo sceglie anche il nuovo nome collettivo, prima inesistente o minoritario, e la lingua comune. In altri termini, è lo stato, per quanto a livello embrionale e su basi ancora incerte, a produrre la nazione e non viceversa[3].
Chiamata etno-genesi questa teoria ebbe subito rapida e vasta fortuna. Non ci si mise molto a capire che si trattava di un processo estensibile ovunque. A Roma antica, per esempio. Chi erano i Romani? Etruschi, Latini, Sabini, Equi, Rutuli e via dicendo fusisi insieme per dare vita a un’unica realtà, statale e culturale. Lo stesso era già accaduto a Cartagine, dove i Punici erano Fenici incrociatisi con gli Africani preesistenti, e ad Atene. I popoli non sono, ma si formano in un tempo e in un luogo. Accade perché qualcuno li concepisce, dotandoli di una prima infrastruttura culturale, di un nome e di Miti di fondazione. Al resto pensano le circostanze storiche, in particolare quando un gruppo emergente riesce a creare uno stato: sarà questo, poi, a plasmare la nuova nazione attraverso le prove a cui la comunità sarà sottoposta. Come avevano già scoperto Spartani e Romani, le cui costituzioni materiali originarie erano modellate sull’esercito e le necessità del reclutamento, niente più di una guerra determina il sentire collettivo. Con il pericolo, le speranze, le delusioni, le distruzioni e i lutti condivisi. Specie se alla fine trova qualcosa che può chiamare vittoria. A questo punto è nata una nuova nazione, con i suoi Miti. I quali non hanno maggiore fondamento di qualunque altro scelto al suo posto.
La conclusione è inevitabile: il nazionalismo ha rappresentato un potente fattore di costruzione e distruzione nel corso degli ultimi due secoli. Ha avuto una funzione positiva quando è riuscito ad aggregare, devastante tutte le volte che ha creduto reali le sue stesse leggende e le ha usate per giustificare l’annientamento dei “concorrenti”. Se fossimo capaci di utilizzare la lezione del passato e gli strumenti fornitici dalla Storia, potremmo sfruttare gli insegnamenti dell’etno-genesi per forgiare le nuove nazioni del XXI secolo. Quelle che servono, qui e ora. A partire dall’europea. La sfida, oggi, è soprattutto questa.
[1] George Mosse, La cultura dell’Europa Occidentale (nell’Ottocento e nel Novecento), traduzione di Savino D’Amico, Saggi, Milano, Mondadori, 1986, Introduzione, p. 9.
[2] Andrè Du Toit, No Chosen People: The Myth of the Calvinist Origins of Afrikaner Nationalism and Racial Ideology, The American Historical Review 88, no. 4 (1983):, pp. 920–952.
[3] Walter Pohl, «L’universo barbarico», AA. VV. Storia medievale, Roma, Donzelli Editore, 1998.