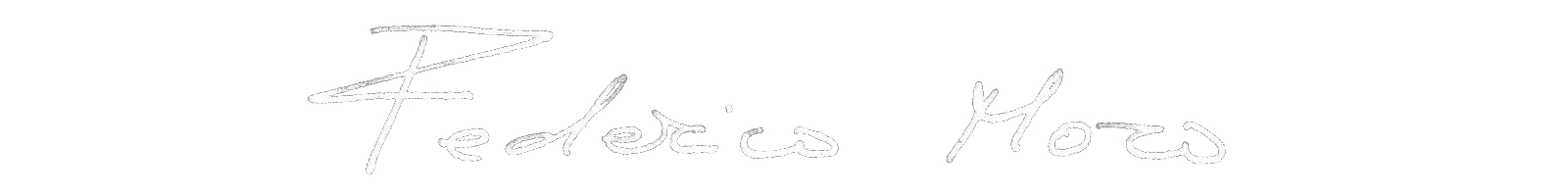Diciamo la verità, il triennio 2019-2022 sarà probabilmente ricordato come un periodo davvero complicato: fenomeni metereologici estremi, pandemia, recessione globale, infine guerra mondiale. La Quarta secondo il mio personale computo, che assegna la terza posizione a quella chiamata Fredda, conclusasi nel 1991 con la sconfitta e dissoluzione dell’Unione Sovietica e del suo progetto politico. Forse adesso avremo pure una carestia generale, innescata dalle distruzioni fisiche e finanziarie provocate dal conflitto in Ucraina e Russia. Si verificasse, verrebbe a farci visita anche l’ultimo dei Cavalieri dell’Apocalisse e a quel punto potremmo aspettarci la venuta dell’Anticristo per chiudere il cerchio. Catastrofico? Forse. Realista? Senz’altro. È bene qualcuno lo sia dalle nostre parti, intendo in Italia, perché nella Penisola ci si è abituati a vivere come nel Paese dei Balocchi, spazio fantastico dove i sogni si materializzano per incanto: Mariupol, Bucha, Kharkiv, invece, sono lì a dimostrarci quanto ci sbagliavamo. Non siamo un’isola dorata, nemmeno una semplice isola.
La considerazione dovrebbe essere evidente, così come le conseguenze che ne discendono. Patrimonio condiviso, dunque? Nient’affatto. A dispetto del fosco quadro generale, infatti, la nostra classe politica si sta di nuovo frantumando nelle tradizionali cento parrocchie in cerca di uno spicchio di visibilità momentanea. La motivazione risiede nella convinzione che ciò porti a un qualche vantaggio elettorale. Perché a giugno si vota per rinnovare numerose amministrazioni locali e ormai la fine della legislatura incombe. Stavolta, giusto per usare una metafora bellica, qualunque risultato finale si tradurrà in un bagno di sangue per molti a causa della massiccia riduzione dei seggi, tanto al Senato che alla Camera. Molti, tanti, resteranno a casa, la maggior parte dei partiti e dei movimenti, variamente formatisi nel tempo in virtù della solita disgregazione delle formazioni iniziali, sparirà. Per sempre. Il nervosismo, dunque, regna sovrano. Strategia? Impossibile quando l’orizzonte si limiti a qualche mese. Bene Comune? Ammettiamolo, non è mai interessato a nessuno. Eppure l’Italia si trova sul crinale di una svolta epocale, invischiata in una guerra, ancora alle prese con la recessione, mai davvero superata, e con la pandemia da Sars-Covid19 di cui ci siamo dimenticati senza averla sul serio sconfitta. Il cambiamento climatico, poi, continua a colpire. Per tutte queste ragioni una strategia è indispensabile. Ci si voglia pensare o meno. Proviamo a ragionarci sopra, nell’attesa del rinsavimento di chi si aggira tra Palazzo Madama e Montecitorio in tutt’altri pensieri affaccendato,
Due punti di partenza. Primo: l’Italia è la culla dell’Occidente. Come idea, insieme di valori, progetto esistenziale. Noi siamo Occidente sia da un punto di vista culturale che di civiltà, come ho scritto in un articolo il 16 marzo scorso. Possiamo anche far finta di nulla, ma è così. Come tali siamo percepiti dagli altri e anche questo conta. Secondo: l’Italia è Occidente per obiettivo interesse nazionale. Suggestioni personali a parte, tutto ci lega a questa dimensione. Storia, economia, sicurezza. Lo siamo sempre stati e ciò comporta che ne seguiamo le sorti. Se l’Occidente perde e “cade”, noi precipitiamo con esso. Se vince, ne godiamo il successo. Non esiste una via d’uscita. L’ho già scritto il 6 marzo scorso e ripetuto il 5 aprile, sempre su queste pagine. Quanti si credono neutrali ed estranei al destino dell’Occidente, semplicemente sono vittima di un abbaglio, pericoloso, potenzialmente fatale.
Un veloce sguardo alla nostra storia dimostra, infatti, che siamo finiti male quando abbiamo unito il nostro destino all’Impero di Terra dominante al momento; bene se la nostra scelta si è spostata sull’Impero di mare egemone; benissimo quando l’Impero in questione siamo stati noi. Non occorre l’Intelligenza Artificiale, AI per gli anglomani, di un elaboratore quantistico per trarne le relative conclusioni. A prescindere, dunque, dalla lezione fondamentale della Storia: gli Imperi di Mare vincono sempre contro quelli di Terra[1]. La ragione è presto detta: il Pianeta è chiamato Azzurro a causa della sua superficie, coperta per circa il 70% da acqua. Quindi, il mare circonda sempre la terra e dal mare si può “ingabbiare” qualunque signore di terra. Russia e Cina non soffrono di “sindrome da accerchiamento” per caso. È proprio così, in realtà. Il fatto sia bene le cose continuino a stare in questo modo è un’altra faccenda.
D’altronde, il 90% del commercio internazionale, il “motore del Mondo” per usare un’espressione cara ad Alfred T. Mahan, avviene via mare. Curiosamente, ciò vale solo per 30% nel caso dell’Italia, che privilegia per il 44% la strada e riserva alla ferrovia il restante 16% circa. È un’anomalia, come ben sappiamo, la quale rappresenta un irrisolto problema logistico. Noi siamo un paese povero di materie prime, che è vissuto sin dall’Antichità quale loro importatore per trasformarle in manufatti ad alto valore aggiunto. Nonché, e sarebbe bene cominciare a ricordarselo, in quanto fornitore di servizi avanzati in campo finanziario, collegati alla movimentazione di merci e denaro. Grazie anche alla sua centralità politica, quale sede del potere imperiale prima, di quello universale della Chiesa dopo, e del controllo esercitato sulle rotte marittime a lunga distanza in seguito. Il Bel Paese, infatti, è votato al mare a partire dalla constatazione che si tratta di una penisola proiettata nel Mediterraneo, bacino centro da sempre del Mondo. Dall’Europa è separata dalla catena delle Alpi, mentre la sua costa orientale è lambita dall’Adriatico, autostrada liquida che porta verso il cuore del vecchio Continente. Trieste è il punto di costa più vicino al mare per il Centro Europa. Le rotte che escono dal Canale d’Otranto lo uniscono al Levante Mediterraneo e da qui all’Asia. Allo stesso modo, solo il modesto Canale di Sicilia lo separa dall’Africa. Lo Stretto di Gibilterra è la strozzatura che controlla le comunicazioni con l’Atlantico; Canale di Suez e Stretto di Bab el Mandeb quelle con l’Indo-Pacifico.
Una strategia per l’Italia deve partire da qui. Lo aveva capito Roma repubblicana e imperiale, ma anche il variegato mosaico di comuni e signorie altrimenti poco dotate di territorio e risorse ma capaci per secoli di raggiungere un tale livello di benessere e dimensione culturale da saturare d’arte ogni più sperduto paesello. Dopo aver preso atto di tutto ciò, cosa ci serve? Innanzitutto, chiarezza di obiettivi. Il primo punto è capire che viviamo in un mondo complesso dove non esiste alcuna separazione tra “pacifica competizione” e “guerra militare”: entrambe sono polarità estreme della medesima realtà, tra le quali si estende una profonda e variegata fascia intermedia di situazioni. Sempre in movimento, eternamente fluide, pronte a rovesciarsi da un momento all’altro nel loro contrario. Non è una caratteristica della contemporaneità e questo ci aiuta, mettendoci a disposizione la lezione della storia per elaborare la migliore strategia. In materia, Venezia rappresenterebbe un buon esempio da studiare e imitare. Nessun retroterra particolare, nessuna risorsa di base eppure lungimiranza politica, capacità di far prevalere l’interesse nazionale su quelli di parte, totale spregiudicatezza nell’uso di qualunque strumento utile al raggiungimento degli scopi: dalla diplomazia, al blocco commerciale, dall’assassinio politico a potenti flotte pronte all’istante a esercitare la forma di coercizione ritenuta più efficace. C’è da imparare.
A cominciare da una constatazione che urterà molte “anime belle”: bisogna tenere sempre la guerra lontano dalla soglia di casa. Come dimostra oggi l’Ucraina, puoi benissimo combattere nelle tue città, ma ne paghi un prezzo spaventoso. Per generazioni. La guerra dev’essere messa in conto. È una semplice variante armata della politica, come ci hanno ammonito invano Macchiavelli e Montecuccoli ben prima di Clausewitz, e quindi non è eliminabile dalla Storia con un atto di volontà. Dovremmo saperlo meglio di chiunque avendo sottomano la Chiesa Cattolica, con le sue Crociate e gli infiniti roghi accesi ovunque. Deus lo vult! È stato solo un modo in cui si è declinata la ragion di stato oggi diventata interesse nazionale. Tenere la guerra lontano è un bel proposito, ma si traduce col disporre di un braccio lungo capace di mescolare nelle proporzioni migliori diplomazia, potere economico, pressione culturale e militare. Nessuno può permettersi di essere considerato debole o troppo molle nell’uso della forza, se vuole rimanere libero e avere voce sul proprio destino. Il che significa, però, anche disporre di una deterrenza credibile, che chiunque sa verrebbe usata quando necessario. Strutturata su vari livelli, con capacità d’intervento a largo raggio.
Non potendo contare su nessuna forma di autosufficienza, l’Italia deve avere come ulteriore obiettivo di mantenere sempre aperte e sotto controllo le vitali vie marittime: la rotta Bab el Mandeb/Suez-Gibilterra, dai terminali oceanici e per tutto il suo percorso, certamente, oltre che avere il completo controllo delle strozzature “di casa”, Canale di Sicilia e d’Otranto, tanto per cominciare. Naturale corollario è evitare di trovarsi nella situazione del gas russo: un solo fornitore per una materia prima essenziale. Si è trattato di una leggerezza imperdonabile. Bisogna avere più fornitori e non essere mai nelle condizioni di venire strangolati. Il che comporta la capacità di andarsi a prendere ciò che serve dove si trova, se messi alle strette. O di poter fare tanto male da sconsigliare chiunque dal percorrere questa via. È scontato che questo presupponga una capacità di difesa del territorio e delle attività nazionali a partire da qualunque minaccia arrivi dallo spazio, dal cielo, dalle reti informatiche. Anche da terra e dal mare, perché i trattati sono una bellissima invenzione, ma hanno un difetto di fondo, come ben ci insegnano i veneziani del passato: non valgono neppure la carta su cui sono stati scritti. Vale per tutti. Vale per chiunque.
Una strategia per l’Italia dovrebbe interiorizzare e portare a pieno compimento un celebre passo di un discorso tenuto alla Camera dei Comuni da Lord Palmerston nel 1848, quando l’opposizione lo attaccava per il Trattato di Adrianopoli, sottoscritto con l’Impero Ottomano: «We have no eternal allies and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual and those interests it is our duty to follow (Non abbiamo alleati eterni e non abbiamo nemici perpetui. I nostri interessi sono eterni e perpetui e questi interessi è nostro dovere perseguire)[2].» Un’altra lezione della Storia che Venezia aveva già anticipato a nostro beneficio. Certo, a patto di non cadere nell’abbaglio che tutto si risolva nella lotta per una poltrona a Montecitorio o Palazzo Madama. Le risposte dipendono dalle domande e da come queste sono poste, l’orizzonte varia a seconda del punto di vista. Dal buco di un pozzo non si può vedere il mare.
[1] Pur essendo sempre esistita nei fatti, connaturata com’è all’intima natura dell’homo sapiens, in genere si fa risalire la nascita della Geopolitica come scienza moderna ai tedeschi Friedrich Ratzel, al quale si deve nel 1901 l’invenzione del concetto di lebensraum o “spazio vitale” ripreso da diversi epigoni e quindi da Adolf Hiter nel Mein Kampf, e a Karl E. Haushofer, Geopolitische Grundlagen, Berlin und Wien, Spaeth & Limbe, 1939. Haushofer introduce le idee di “stato organico”, “autarchia”, “panregioni” e riprende da Ratzel quello di “spazio vitale”. Sono tre autori anglosassoni, tuttavia, a svilupparla in maniera completa. Il primo è Alfred T. Mahan, The Influence of Seapower upon History, 1660-1783, (1890) at archive.org e Id. The Influence of Seapower upon French Revolution and Empire, 1793-1812 (1892) at archive.org, dove viene evidenziata la fondamentale importanza del Dominio del Mare per conseguire quello del Mondo. Un esito del tutto diverso dalle tesi di Mahan ha la riflessione dell’inglese Halford J. Mackinder, «The Geographical Pivot of History», The Geographical Journal, vol. 23, n. 4 (April 1904) e Id. Democratic Ideals and Reality. A Study in the Politics of Reconstruction, Washington DC, National Defense UP, 1996 come poi analizzato di recente da Anita Sengupta, Heartlands of Eurasia. The Geopolitics of Political Space, Washington DC, Lexington Books, 2009. La prospettiva di Mackinder è riassumibile nella frase: «Who rules East Europe commands the Heartland; who rules the Heartland commands the World-Island; who rules the World-Island commands the World (Chi domina l’Europa Orientale controlla il Cuore del Pianeta; chi domina il Cuore del Pianeta controlla l’Isola-Mondo [cioè Eurasia e Africa, NdR]; chi domina l’Isola-Mondo domina il Mondo)», Id. 1996, p. 150. Un approccio rovesciato dallo statunitense Nicholas J. Spykman, America’s Strategy in World Politics: The United States and the Balance of Power, New York, Harcourt-Brace & Co, 1942 e Id. The Geography of the Peace, New York, Harcourt-Brace & Co. 1944: riprendendo la riflessione del connazionale Mahan, Spykman inventa il concetto di Rimland ovvero di fascia costiera e marittima che circonda Heartland, cioè il Cuore del Pianeta di Mackinder. Secondo Spykman è il dominio del Rimland a garantire il controllo dell’Eurasia e quindi del Mondo. Un approccio da cui deriva il tradizionale prevalere degli Imperi di Mare su quelli di Terra in virtù del dominio esercitato sulle rotte marittime a lungo distanza, arterie su ci scorre il mahaniano motore del Mondo, vale a dire il commercio internazionale.
[2] Henry J. Palmerston, Treaty of Adrianople, charges against Viscount Palmerston, HC Deb 01 March 1848, vol. 97, cc-122 (intero discorso Ivi cc 66.123), api.parliament.uk/history.