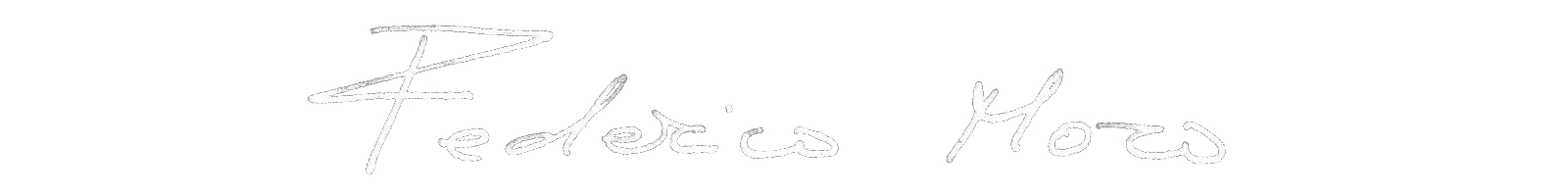La caduta di Kabul e la fuga di americani e alleati dall’Afghanistàn hanno sollevato prima stupore e quindi un aspro dibattito. L’innesco è stato fornito dalla rapidità del crollo dell’impalcatura statuale e militare alzata dall’Occidente in quel paese, dove vent’anni di lavoro e presenza di soldati sul terreno sono stati vanificati nel giro di una manciata di settimane. Inevitabile la frustrazione per una sconfitta che a molti ha ricordato l’analoga in Viet-Nam. Anche in alcuni aspetti per così dire formali, quale la disperata fuga aerea di chi sia riuscito a trovare un posto sui velivoli in partenza e la gran massa di armi e materiali abbandonati sul posto. A qualcuno, infine, ha fatto particolare specie vedere gli equipaggiamenti destinati alle forze speciali afghane ostentati in strada da quelle appena costituite dei vincitori, i Talebani. Anche solo dal punto di vista della comunicazione visiva, un disastro.
Scontate a questo punto le critiche rivolte all’Amministrazione Biden che ha gestito l’evento. Questa, però, è solo l’ultima di quattro diverse, due repubblicane e due democratiche, coinvolte nella gestione della vicenda afghana. Gli uomini di Biden, dunque, si sono trovati nella sostanza ad affrontare problematiche determinate dai predecessori. Mai dimenticarsi che a decidere l’intervento è stato il repubblicano Bush e a firmare l’accordo con i Talebani l’altrettanto repubblicano Trump. Un po’ la nemesi del Viet-Nam, dove furono i democratici Kennedy e Johnson a coinvolgere gli USA nella guerra e il repubblicano Nixon a tirarli fuori. Questo dimostra che le decisioni geostrategiche di lungo periodo sono assunte in riva al Potomac in base a valutazioni che prescindono dalle convinzioni ideologiche sbandierate, ma obbediscono, come giusto che sia, al più stretto pragmatismo. Quasi a dispetto della premessa, però, la scelta di abbandonare Kabul segna una formidabile discontinuità rispetto agli orientamenti politico-militari emersi a partire dagli anni Novanta del Novecento.
È stato il periodo della Superpotenza Unica, dell’America “gendarme del Mondo” dell’ubriacatura da “fine della storia” stile Fukuyama. Adesso hanno scoperto, quasi con raccapriccio, che la storia non è affatto conclusa, così come l’accoppiata libero mercato-democrazia non riesce a esercitare ovunque lo stesso fascino magnetico. Passiamo ai dati di fatto, però. Il problema di fondo è che gli USA si sono resi conto che mantenere il ruolo di Superpotenza Unica costa troppo. Per cercare di conservarlo, negli ultimi trent’anni le spese militari dirette e indirette sono impazzite, drenando risorse di cui il paese avrebbe avuto disperato bisogno al suo interno. Gli effetti si vedono in ogni campo, dalla sanità ai trasporti, dalla scuola all’energia. Vale oggi per gli Stati Uniti quanto a metà Ottocento diceva della Gran Bretagna il primo ministro di allora, Disraeli: “Uno stato con due nazioni: i ricchi e i poveri.” Con disparità sociali rintracciabili solo nel Terzo Mondo, aggiungo.
Il problema è aggravato dal fatto che tutto questo tempo è stato sfruttato da un nuovo attore politico per procedere a un’incredibile accumulazione di ricchezza e sapere tecnologico. Parlo della Cina, ovviamente, la quale dall’alto della forza economico-finanziaria e della compattezza sociale di cui finora ha dato prova si è lanciata in una corsa agli armamenti seconda sola a quella americana. Forse allo stesso livello. Il nano strategico è cresciuto al punto da lanciare apertamente la sfida all’avversario a Stelle &Strisce. Non c’è niente di nuovo o di strano in questo.
La conquista dell’egemonia mondiale è sempre il vero obiettivo finale di ogni stato con dimensioni e risorse adeguate a osare l’impresa. Si tratta della vocazione naturale della forma-stato in quanto tale, cioè della più efficiente struttura organizzata del vivere associato finora creata dall’Homo Sapiens. Una specie parte integrante del tutto organico attraversato da un solo soffio vitale oggi chiamato comunemente Gaia, caratterizzato però dal curioso coesistere di unità e feroce lotta per la sopravvivenza tra le specie. Battaglia da cui esce vincitore non il più forte in assoluto, bensì colui con la migliore capacità adattativa cioè abile a piegarsi e a modificare a proprio vantaggio il vorticoso e continuo cambiare di ambiente e concorrenti. Se noi mettiamo in fila tutti questi elementi e li consideriamo come maglie di una sola rete di interconnessioni, siamo in grado di comprendere tanto le ragioni dell’intervento americano nella regione un tempo chiamata Bactria da persiani, greci parti, kushana e quindi diventata Afghanistàn quando l’Islàm si affacciò da conquistatore; quanto gli insuccessi sovietici e americani negli anni settanta del Novecento e oggi. Possiamo capire, inoltre, perché l’ombra che si allunga dietro i successi talebani porti il nome di Pakistàn e, soprattutto, Cina.
Gli Usa d’inizio Millennio uscivano dalla vittoria nella Terza Guerra Mondiale, nota anche come Guerra Fredda. Hanno creduto, al pari della Roma di Marco Ulpio Traiano, di non avere rivali possibili e che lo strapotere economico-finanziario in grado di creare la Rivoluzione Digitale, premessa di una nuova Rivoluzione Militare capace di rendere invincibili le legioni di Washington, potesse durare a lungo. L’idea era di trasformare quello a Stelle&Strisce in un altro “impero senza fine”, come scrisse Tacito a proposito del dominio romano. Potremmo chiamarla la “Trappola di Fukuyama”: economia di mercato, democrazia liberale, potenza digitale avrebbero costituito la triade capace di traghettare il secolo americano dal Secondo al Terzo Millennio. Un sogno del tutto simile a quello di Traiano che portò alla massima estensione il limes, includendovi Dacia e Mesopotamia. Contava di eliminare gli avversari più pericolosi del momento. Ci riuscì. Troppo forti le legioni. Furono successi effimeri, però, in particolare in Mesopotamia. Il successore Adriano preferì ridurre l’ampiezza del perimetro da difendere. In Britannia costruì un Vallo che il successore Antonino Pio pensò di spostare in avanti, lungo un tratto di territorio più breve e quindi, in teoria, meno difficile da proteggere. Come già era successo ad Augusto e Tiberio in Germania, accadde che la linea ideale non corrispondesse a quella possibile da tenere. Per questo Augusto aveva rinunciato a raggiungere l’Elba dopo Teutoburgo, le famose tre legioni di Varo annientate nella foresta, e Tiberio dopo il trionfo di Germanico a Idistaviso e al Vallo Angrivariano, in cui annientò Arminio e la confederazione germanica guidata dai Cherusci vincitori contro Varo, recuperando due delle tre aquile perdute e fissando per sempre il limes lungo i corsi del Reno e del Danubio.
Il principio a cui si ispirarono gli imperatori romani fu quello che non si può tenere nessuna linea se alle spalle si ha un territorio ostile, perché in sostanza non esiste la possibilità di assimilare popolazioni refrattarie ad accogliere la cultura e la civiltà proposte. Mancando tale premessa, la partita è persa in partenza. Per questo in Britannia il Vallo di Antonino, senz’altro in posizione migliore, viene abbandonato a favore di quello di Adriano; la Mesopotamia viene sgombrata e così accadrà anche alla Dacia. Il principio strategico, dunque, è l’adattamento alle condizioni sociali reali, persino la geografia passa in secondo piano. Un’ammissione formidabile per un impero come il romano, assolutamente convinto, a ragione, dell’indiscutibile superiorità della propria civiltà. Avrebbero dovuto comprenderlo i sovietici quando presero la decisione d’invadere l’Afghanistàn, ancora di più gli USA nel ritentare l’impresa una ventina di anni dopo. Particolarmente grave nel secondo caso, quando l’esperienza russa aveva appena dimostrato come una guerriglia che disponga di santuari oltreconfine e rifornimenti continui, sia in sostanza invincibile. Viet-Nam docet, verrebbe da aggiungere.
Come sempre accade in questi casi, c’è chi è pronto ad approfittarne. I competitori crescono mentre l’attenzione è distratta da un fronte complesso, si arricchiscono perché le risorse dell’avversario sono assorbite dalla/le guerra/re e intanto preparano un salto qualitativo. È quanto successo con la Cina. Il Dragone si è svegliato, ha avviato un riarmo esteso, il vantaggio tecnologico occidentale si è ridotto e la soglia della “trappola di Tucidide” si è avvicinata in modo pericoloso. Washington si è trovata di fronte alla necessità di scegliere quale nemico privilegiare, dove concentrare uomini e risorse. In particolare le seconde. Il disimpegno dai teatri secondari è diventato urgente. Per cui, via anche dall’Afghanistàn. In sostanza a qualsiasi costo. Il prezzo dell’orgoglio sarebbe davvero sproporzionato. Adesso la prima linea corre nel Mar Cinese Meridionale, è d’obbligo bloccare il Dragone all’altezza della prima catena di isole, impedendogli di avere libero transito fino all’Oceano aperto. Fatto che si tradurrebbe subito nel suo controllo effettivo, e non più facilmente aggirabile, tanto della prima che della seconda catena di isole. Taiwan finirebbe per cadere, la Corea e il Giappone sarebbero in trappola, tutto quanto è in mezzo fino all’Australia diventerebbe campo di battaglia. Meglio andar via subito dall’Afghanistàn, ma anche dalla Siria e dall’Iraq e intanto tornare ad alimentare guerre civili e guerriglie da sempre endemiche nel mondo islamico. Perché i Talebani sono sunniti oltranzisti e si odiano con gli sciti, gli Hazara dalla notte dei tempi sono considerati eretici da convertire dai Pashtùn. È sempre più facile appiccare incendi che spegnerli.
Per questo, alla fine, resta il dubbio: Afganistàn, una sconfitta? Per chi ama vincere spazzando via gli avversari sì, ma di fatto il presidente cinese Xi Jiping ha rispolverato la vecchia giacca in stile maoista e già dichiarato che nessuno può pensare di basare la propria esistenza sul puro e semplice arricchimento individuale. Perché anche nel rinnovato Celeste Impero bisogna cominciare a pensare a come pagare le spese militari. Le portaerei, i caccia di quinta generazione e i missili balistici intercontinentali costano. Ovunque. Non è un problema solo in riva al Potomac. L’era dei soldi facili è finita anche dalle parti del Fiume Giallo, passa da “fabbrica del Mondo” ad aspirante egemone dello stesso ha un prezzo. Il primo è la concentrazione delle risorse sugli strumenti necessari a conseguire i fini perseguiti. Gaia resta un posto dove regna una sfrenata competizione chi non vince e cresce, semplicemente, decade e scompare. A Venezia abbiamo avuto un caso di scuola in materia. Sarebbe ora che l’Europa nel suo complesso cominciasse a studiarlo e a riflettervi con attenzione.