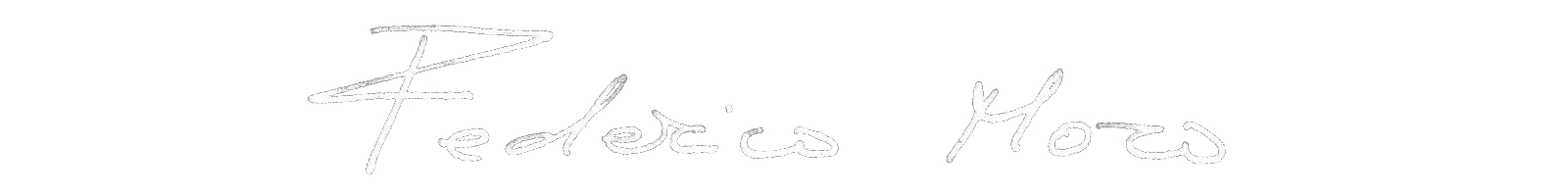Uno dei problemi più dibattuti a Venezia, ormai da anni, è quello relativo alla “visione della città futura”. Sempre se ne possieda una. Ricerca ormai ansiosa: che serva una “visione” ognun lo dice, dove si trovi nessun lo sa. Non l’ha avuta nemmeno il sindaco-filosofo Massimo Cacciari, dominus incontrastato della vita pubblica lagunare per almeno un ventennio, mica poco a pensarci bene, il quale non è riuscito a incidere sulle dinamiche sociali, economiche e culturali che ci hanno condotto fin qui. Men che meno i successori, fino all’attuale sindaco, Luigi Brugnaro, che si dedica al pari dei predecessori al piccolo cabotaggio amministrativo, cercando di non decidere mai nulla davvero. Stessa musica a ogni altro livello amministrativo e/o politico. Insomma, pare che nessuno abbia la minima idea su cosa si possa e/o si debba fare di questa scialuppa di pietra quasi alla deriva, ormai, nell’Adriatico deciso a riprendersela. Temo non si siano usati gli strumenti giusti finora, perché sostenere, come è d’uso, che la “città futura” dovrà essere aperta, inclusiva, dall’identità forte ma allo stesso tempo curiosa, cosmopolita, ponte tra mondi e porta sul mondo, adesso anche verde e sostenibile, priva di barriere fisiche e spirituali, non ha alcun significato: restiamo nel campo del generico capace di accontentare qualsiasi palato, proprio per l’assenza di contenuto concreto. Poiché nel corso del nostro viaggio, mi riferisco alla serie Occorre un pensiero, ci siamo dotati degli strumenti necessari, proviamo un po’ a usarli.
La meta, dunque, è chiara e l’abbiamo appena descritta, dobbiamo tracciare la rotta per arrivarci usando i mezzi di cui ci siamo dotati: la soluzione più semplice consiste in una ricognizione del passato, perché se trovassimo degli esempi interessanti potremmo analizzarli e tentare di adattarli al presente. Al fine di trasformarlo in futuro. Niente di più del modo corretto di sfruttare la storia, direbbe qualcuno. In questo caso, proprio lei, la storia, ci fornisce un aiuto immediato: nel volume Sea power states, che cito spesso, l’inglese Andrew Lambert espone cinque casi di studio a sostegno della sua teoria sull’esistenza di una cultura marittima produttrice di società con le caratteristiche appena ricordate. Guarda caso il terzo di questi è proprio Venezia. La quale viene considerata prova di cosciente adozione di tale approccio, di sua trasmissione nel tempo e di migliore risultato finale. Gli altri sono l’Atene da Temistocle a Pericle, la Cartagine dalla fondazione ai Barca, l’Olanda del Seicento e l’Inghilterra dei secoli XVIII e XIX. Sotto ogni punto di vista una buona compagnia.
Risulta di particolare interesse nello studio la considerazione per cui la cultura marittima non viene considerata come innata o legata ad alcune caratteristiche geografiche particolari, bensì frutto di una scelta deliberata perseguita nel tempo attraverso la sua successiva trasmissione, generazione dopo generazione. Quando la catena s’interrompe, se ne perdono le caratteristiche e quindi anche i relativi benefici in termini di caratteristiche sociali, economiche, di civiltà. Questo perché così come si acquista per atto di volontà, in sostanza, altrettanto facilmente si perde se non viene coltivata. Da qui il fenomeno, altrimenti spesso inspiegabile, della decadenza degli stati un tempo potenze marittime. Il patrimonio è andato disperso. Come accadde a Venezia, trasformatasi da realtà mercantile proiettata verso il mondo intero a città dove la sua classe dirigente viveva di rendita fondiaria, per altro estesa dall’Adda all’Isonzo e dall’Istria alla Dalmazia. Sviluppando gradualmente le chiusure tipiche delle società basate sul possesso e la coltivazione della terra, nonché di patrimoni immobiliari.
La cultura marittima di cui si parla, quindi, non è certo quella, per altro benemerita, di chi realizza forcole, gondole, barche tradizionali lagunari o tiene in vita antichi squeri: si sta ragionando del grande commercio internazionale lungo rotte a grande distanza. È questo ad avere prodotto nel passato l’Atene di Pericle, Cartagine, la Venezia medievale e rinascimentale, l’Olanda del secolo d’oro e l’Impero Britannico. Giusto per rimanere nel perimetro disegnato da Lambert. Ai giorni, nostri, ovviamente, dovremo misurarci con lo stato dell’arte in materia navale e portuale. Veniamo, quindi, al nocciolo del problema. Se cultura marittima dev’essere, questa si sviluppa attraverso navi e porti. Tutto il dibattito sulla “visione futura” di Venezia, pertanto ruota necessariamente attorno alla centralità del porto. Il quale non è solo un’azienda attorno alla quale se ne sviluppano infinite altre, un aggregato economico-finanziario dunque, e neppure di un’appendice, sia pure tradizionale, che si possa impunemente amputare. Al contrario, la sua rilevanza per la “cultura marittima” della città è tale che si potrebbero perfino invertire i termini del rapporto causa-effetto: prima venne il porto, dotato delle installazioni militari esterne per proteggerlo, e soltanto in seguito si aggiunse l’urbanizzazione. Un porto- città, dunque, e non una città-porto. La quale altro non era che una costellazione di punti fortificati collegati da vie d’acqua i quali, per sopravvivere e svilupparsi, scoprirono l’utilità di unirsi. Da un punto di vista costruttivo e politico-militare.
A questo punto giunse la grande scelta definitiva: barattare la terra con il mare. La ragione per cui il porto rappresenta da sempre il vero cuore e l’anima di Venezia, motore della cultura marittima indispensabile alla sua esistenza. In quanto ne rappresenta plasticamente l’identità. Ed è evidente che le navi in questione non siano mascarete, né topete, ma neanche caorline o burci, bensì navi mercantili per il trasporto merci a largo raggio. Neppure in senso stretto, dunque, unità da crociera, altra modalità del consumo turistico della città, interessanti soltanto per via della Fincantieri di Porto Marghera, che ne costruisce non poche. Merci, dunque, le più diverse, provenienti e dirette ovunque nel mondo. Questa è l’essenza di un vero porto, da sempre e per sempre. L’unica via per cominciare a ritrovare il filo perduto di quella “cultura marittima” andata dispersa per l’incuria di una classe dirigente patrizia che abbandonò il mare per la terra, le corsie delle galee e i ponti dei vascelli per le ville in campagna. Senz’altro capolavori artistici, il più delle volte, ma autentica zavorra per uno stato che doveva mantenersi “marittimo”.
Nella prossima puntata affronteremo l’altra questione spinosa: porto, va bene, ma quale?